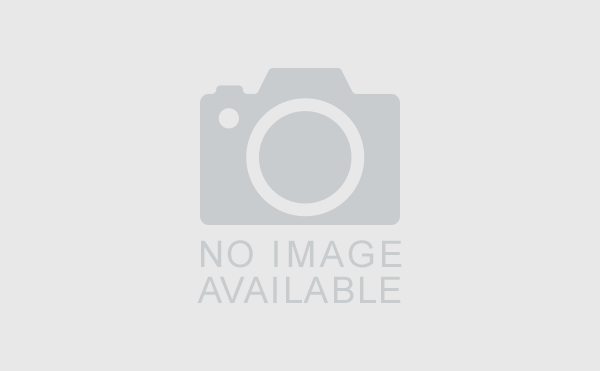𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Le Sezioni Unite sulla funzione e sulla forma del patto fiduciario
Le Sezioni Unite sulla funzione e sulla forma del patto fiduciario
#pactumfiduciae #forma #sezioniunite #2932cc
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020
Si segnala questa importante pronuncia delle Sezioni Unite sulla efficacia e sulla forma del pactum fiduciae che imponga il (ri)trasferimento di un immobile dal fiduciario al fiduciante.
L’inquadramento del fenomeno fiduciario
La Corte opera, innanzitutto, una ricognizione delle molte manifestazioni del negozio fiduciario.
Esso“dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell’esercizio del diritto fiduciariamente acquistato” e più che come una fattispecie unitaria, si presenta come “una casistica”.
Limitandosi al caso in cui il pactum fiduciae si articola mediante l’intestazione di un bene immobile al fiduciario, lo scopo negoziale può essere perseguito mediante un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, ma anche mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante. In alcuni casi, poi, non v’è un vero e proprio effetto traslativo in quanto “manca del tutto un atto di trasferimento, perché il soggetto è già investito ad altro titolo di un determinato diritto, e il relativo titolare, che sino a un dato momento esercitava il diritto nel proprio esclusivo interesse, si impegna a esercitare le proprie prerogative nell’interesse altrui, in conformità a quanto previsto dal pactum fiduciae (cd. fiducia statica)”.
Parimenti, la funzione del negozio fiduciario può essere varia. Può trattarsi di un patto riconducibile alla fiducia cum amico allorché l’intestazione del bene è “funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell’interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo” o alla fiducia cum creditore quando il debitore trasferisce la proprietà di un bene al fiduciario, creditore, a garanzia del diritto di credito, con l’impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito; in tale ultimo caso, occorre verificare che non si tratti di un contratto che consenta di eludere il divieto del patto commissorio (2744 c.c.).
In dottrina e giurisprudenza, si sono elaborate diverse ricostruzioni della struttura causale del negozio fiduciario, riconducibili alle seguenti teorie:
- negozio unico caratterizzato da una causa fiduciaria interna(l’effetto obbligatorio non costituisce un limite dell’effetto reale, ma si trova con esso in un rapporto di interdipendenza, non già nel senso di corrispettività economica, ma nel senso che l’attribuzione patrimoniale è il mezzo per rendere possibile al fiduciario quel suo comportamento in ordine al diritto trasferitogli: l’effetto obbligatorio rappresenta dunque la causa giustificatrice dell’effetto reale);
- singoli negozi tipici con causa propria nel quale la fiducia rileva a livello di motivi o di determinazione accessoria di volontà;
- fattispecie di collegamento negoziale (tra contratto traslativo e patto fiduciario) nel quale la causa fiduciae esprime e dà corpo al collegamento tra i due contratti.
La giurisprudenza ha, altresì fatto ricorso alla figura del negozio indiretto: un negozio, cioè, con cui le parti perseguono risultati diversi da quelli tipici del negozio impiegato, e corrispondenti a quelli di un negozio diverso. Il pactum fiduciae prevede, appunto, che il negozio, pur realmente voluto dalle parti, venga attuato in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. L’intestazione fiduciaria di un bene, in questa ottica, comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae.
L’ampia ricostruzione non conduce, tuttavia, la Corte a optare per l’una o per l’altra teoria poiché la questione non rileva nel caso di specie.
Il problema della forma del pactum fiduciae
La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere, infatti, riguarda l’efficacia di un pactum fiduciae meramente verbale pur se relativo al trasferimento di un bene immobile.
Le due tesi
Secondo la tesi prevalente, l’art. 1351 c.c. – che sancisce la nullità del contratto preliminare se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo – esprime un principio generale per i contratti preparatori applicabile anche al pactum fiduciae.
In sostanza, “si riconosce l’esistenza di un collegamento tra l’art. 1351 e l’art. 2392 cod. civ., nel senso che, riferendosi l’art. 2392 cod. civ. a tutti i contratti produttivi di un obbligo a contrarre, anche l’art. 1351 cod. civ. dovrebbe estendersi a tutti i contratti che obblighino i contraenti a stipulare un ulteriore negozio formale, con la conseguenza che la norma non riguarderebbe soltanto il contratto preliminare, ma ogni negozio fonte di successivi obblighi a contrarre, e tra questi il patto fiduciario”.
La tesi in esame esclude che un patto verbale possa fondare l’obbligo al ritrasferimento e anche che l’eventuale dichiarazione scritta unilaterale con cui il fiduciario si obblighi al ritrasferimento possa valere a tal fine; una simile dichiarazione, infatti, non costituisce né elemento integrante il contratto né – quand’anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto –una valida prova del medesimo.
Secondo un opposto indirizzo minoritario la dichiarazione unilaterale, in quanto volta ad attuare il patto fiduciario preesistente, ha, invece, una propria “dignità”, che la rende idonea a costituire autonoma fonte dell’obbligazione del promittente, purché contenga la chiara enunciazione dell’impegno e del contenuto della prestazione. L’impegno, pur nato unilaterale, ha una propria dignità atta a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare l’accordo fiduciario preesistente: “la fiducia è la causa dell’intera operazione economica posta in essere, che si articola in diversi negozi giuridici e che colora di liceità e di meritevolezza l’impegno di ritrasferimento assunto [dal fiduciario] con la sottoscrizione del suo impegno unilaterale” (Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633).
La scelta delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite,pur confermando l’efficacia del patto fiduciario verbale, si discostano dal descritto orientamento minoritario quanto alla centralità della dichiarazione scritta unilaterale con cui il fiduciario si impegni a ritrasferire il bene; a essa è attribuito un rilievo meramente probatorio nel senso che non costituisce fondamento dell’obbligo restitutorio, ma determina la presunzione fino a prova contraria dell’esistenza del rapporto fondamentale (il pactum fiduciae), presunzione che può essere vinta dalla prova contraria eventualmente fornita dal fiduciario-promittente.
L’analogia con il mandato senza rappresentanza
Il ragionamento delle Sezioni Unite si dipana dai principi affermati nella Sentenza n. 20051 del 2013 della sez. III in tema di forma e di efficacia del mandato senza rappresentanza all’acquisto di un immobile.
In quell’occasione, si è ribadito che la forma scritta – richiesta a pena di nullità per gli atti relativi a diritti reali su beni immobili per esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell’atto – è in base agli art. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c. richiesta per la procura conferita dal mandante al mandatario, per il contratto preliminare o definitivo concluso da mandatario a nome del mandante o proprio, e, in questo secondo caso, per il conseguente atto volto a ritrasferire il bene al mandante, la mancanza del quale può essere supplita dall’esecuzione forzata in forma specifica.
Si è, tuttavia, statuito – ed è ciò che maggiormente rileva nel caso di specie – che la forma scritta non può considerarsi imposta anche per il contratto di mandato in sé, perché da questo deriva soltanto, tra mandante e mandatario, l’obbligazione di eseguire il mandato, la cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità per danni. Per converso, una volta che il mandatario abbia effettuato l’acquisto, l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell’atto unilaterale, redatto anche successivamente al detto acquisto, con cui il mandatario riconosca il suo obbligo di farlo, quante volte l’atto contenga l’indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto, o che gli stessi consenta di individuare anche “per relationem“.
Ebbene, anche nel pactum fiduciae, come nel mandato senza rappresentanza, si realizza un’interposizione reale del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute. Non v’è ragione, quindi, di applicare principi diversi da quelli affermati nella citata Sentenza n. 20051 del 2013.
Le differenze con il contratto preliminare
È, invece, negata la stretta analogia tra contratto preliminare e pactum fiduciae che giustificherebbe l’applicazione della medesima disciplina. Si afferma che – al di là della somiglianza legata al fatto che anche nel pactum fiduciae, come nell’obbligo nascente dal contratto preliminare, è ravvisabile un momento iniziale con funzione strumentale rispetto ad un momento finale– la causa e la struttura delle due fattispecie sono differenti.
Nel preliminare, si rileva, “l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale, e lo precede; nel contratto fiduciario l’effetto reale viene prima, e su di esso s’innesta l’effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l’interesse delle parti”.
L’obbligo nascente dal contratto preliminare si sostanzia nella prestazione del consenso funzionale alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò improntato ad una funzione negoziale tipica; “diversamente, nell’atto di trasferimento del fiduciario – analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza (art. 1706, secondo comma, cod. civ.) – si ha un’ipotesi di pagamento traslativo, perché l’atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell’accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina”.
La diversità strutturale delle fattispecie consente di applicare al pactum fiduciae i principi elaborati per il mandato senza rappresentanza con conseguente inapplicabilità dell’art. 1351 c.c. che, negando il principio di libertà delle forme, si caratterizza come norma eccezionale, insuscettibile, quindi, di applicazione analogica.
In entrambi i casi (mandato senza rappresentanza e pactum fiduciae), il contratto ha una struttura debole in quanto il requisito della forma non integra la fattispecie che sorge purché esistano i tre elementi dell’accordo, della causa e dell’oggetto. In simili casi, il principio della libertà della forma impone che non sia necessaria la forma scritta e che l’obbligo sia coercibile anche se manchi la forma scritta.
La libertà delle forme del pactum fiduciae e il valore della dichiarazione unilaterale di impegno a ritrasferire il bene
La forma scritta, è, quindi, richiesta per gli atti che trasferiscano l’immobile, ma non per la costituzione dell’obbligo – meramente interno tra fiduciario e fiduciante – di ritrasferirlo.
L’accordo concluso in tal senso solo verbalmente costituisce una valida “fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum”.
Come si è accennato, l’indirizzo minoritario sopra descritto, a cui pure le Sezioni Unite aderiscono sul piano degli esiti, quindi, è corretto nel senso che la dichiarazione unilaterale scritta valga su un piano esclusivamente probatorio – analogamente a quanto avviene in presenza di una promessa di pagamento – e non, invece, a integrare la validità di una fattispecie che si perfeziona anche all’esito di un mero accordo verbale.
Del resto, osserva la Corte, la fiducia cum amico di rado approda a una formalizzazione scritta degli obblighi del fiduciario in quanto tale formalità sembra negare la stessa fiducia alla base dell’operazione “dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico” (se ci si fida, non c’è bisogno di scrivere alcunché).
L’applicabilità dell’art. 2932 c.c.
Infine, si ribadisce che l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di cui all’art. 2932 c.c. è applicabile “non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege”. Non vi sono, quindi, ragioni per negare l’applicazione del rimedio anche al caso dell’obbligo di ritrasferimento del bene immobile derivante dal pactum fiduciae.
I principi di diritto
La Corte afferma, quindi, i seguenti principi di diritto:
- “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario»;
- «la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.