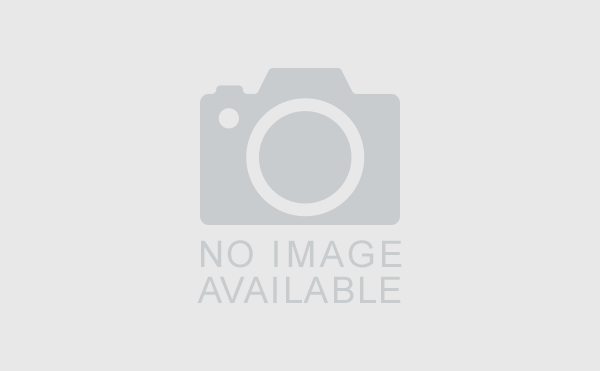𝐈𝐥 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐝 𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢
di Arcangelo Monaciliuni
Nel corso di quest’anno mi sono occupato dei rapporti fra Stato e Regioni in più scritti.
In tutti, ad incipit, la constatazione che l’evolversi del “diritto dell’emergenza”, quale posto e quale (spesso dis)applicato, appariva galoppare di gran passo verso un precipizio istituzionale senza precedenti, tale da riportare alla mia mente l’immagine della parabola dei ciechi di Brueghel il Vecchio.
Sopravvenuta, purtroppo, la (preannunciata) seconda fase dell’epidemia che ha sconvolto le nostre vite, devo amaramente constatare che in quel precipizio siam caduti.
Heri dicebo (in “Il potere di ordinanza nell’era Coronavirus”, in “Lo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioni” ed in “La parabola dei ciechi”, rispettivamente in Calamusiuris del 24 marzo, del 2 aprile e del 14 aprile 2020) ed oggi ripeto, che purtroppo le Istituzioni locali, per contrastare (oggi la seconda fase del)l’epidemia nei propri rispettivi territori non esitano a dettare norme non solo in ordine sparso, ma, per quel che più vale, in aperto e ostentato “contrasto” con lo ius, quale positum dallo Stato nell’esercizio di quel potere straordinario unitario che risiede solo in capo a quest’ultimo.
Che già de iure condito, a Costituzione invariata -ove si sia in presenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c, e dell’art. 24, comma 1, del d.l.vo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero di uno stato di emergenza di rilievo nazionale che non conosce confini, barriere interne, comunali o regionali, oltre a non conoscere nemmeno confini esterni- non sia dato dubitare della preminenza delle potestà statali è assunto ormai suffragato dalle conclusioni della giurisprudenza amministrativa. Ed invero “… in presenza di emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza…”. Cosi in seno a Cons. Stato, sezione prima, parere n. 735/2020 del 7 aprile 2020, recepito integralmente dal d.P.R. del 9 aprile 2020, in G.U. n. 96 del 10 aprile 2020, recante l’annullamento straordinario dell’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 del sindaco del comune di Messina che “chiudeva” lo stretto di Messina. E così, in tali sostanziali sensi, in sede giurisdizionale (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, n. 841 del 9 maggio 2020 e Tar Sicilia, Palermo, n. 1952 del 29 settembre 2020).
A latere, la preminenza delle potestà statali in era Covid è stata espressamente sancita -recte: definita in apposita cornice giuridica- dalla legge.
Ed infatti, (già) l’art. 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conv. in l. 22 maggio 2020, n. 35, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, ebbe a confinare il potere delle Regioni in quello di introdurre misure solo “restrittive” e solo “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri … in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.”, espressamente poi, nello stesso articolo 3, precludendo ai Sindaci l’esercizio di ogni potestà in materia “emergenziale”.
Il legislatore dell’emergenza è poi reintervenuto in eadem res e, dopo aver in un primo momento conferito alle Regioni, “informandone contestualmente il Ministro della Salute”, il potere di introdurre misure derogatorie, (ora) sia” ampliative” che “restrittive”, rispetto a quelle disposte a livello centrale (art. 1, comma 16, del d.l. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), a mezzo dell’art. 1 del successivo, ultimo, d. l. 7 ottobre 2020, n. 125 ha circoscritto il potere regionale alle sole “misure restrittive”, nel mentre per quelle ampliative ha imposto la previa intesa con il Ministro della Salute.
Allo stato dell’arte, le Regioni sono quindi autorizzate ad introdurre per i rispettivi territori -direttamente, immediatamente e senza i limiti previsti dal primigenio dettato di cui all’art. 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conv. in l. 22 maggio 2020, n. 35- misure (maggiormente) restrittive rispetto a quelle imposte in sede nazionale.
Se non che, come accaduto per il passato in riferimento alle diverse pregresse previsioni, anche quest’ultima ha dato luogo ad applicazioni pratiche che appaiono eccedere rispetto al corretto significato da attribuirsi alla locuzione “misure restrittive”, e segnatamente all’ambito della possibile esplicazione del potere di emanazione che difficilmente può essere inteso di ampiezza tale da ricomprendere misure in aperto contrasto con quelle poste a livello statale: ovvero, non finalizzate a “stringere maglie” già poste, ma ad introdurne di nuove, nel caso, come avvenuto nella recente vicenda della “chiusura delle scuole in presenza” disposta dal Presidente della regione Campania, non solo non previste a livello nazionale, ma, apertamente e pubblicamente, ritenute dallo “Stato” non dovute, alla luce dei dati epidemiologici (ben noti anche quelli campani a livello centrale) e delle complessive “politiche” (scelte di fondo) demandate allo Stato.
E tanto, a sottacere che il diritto alla scuola (in presenza) costituisce diritto fondamentale, comprimibile con molta cautela solo a livello statale, ed a sottacere che il principio di leale collaborazione ha da valere per tutti.
E tanto ancora senza dimenticare lo sconcerto ed il disorientamento dell’opinione pubblica.
A rendermelo visivo è stata la risposta datami stamattina dalla persona che il lunedì viene a darci una mano in casa. Alla mia domanda su come avesse pensato di risolvere il problema dei figli (quattro di età molto diverse), mi ha guardato ed ha risposto: “Ma come, ho sentito Conte in TV; il problema è stato risolto; andranno tutti a scuola”. Ecco, lei non si occupa di diritto, e quindi di riparto di competenze fra Stato e Regioni, di efficacia, inefficacia, nel caso sopravvenuta, degli atti amministrativi e così di seguito, ma di certo è rimasta attonita nel sentirsi dire che non era esattamente così.
Ma allora, raccogliendo le fila, mi chiedo se, in un processo di adattamento dello ius positum alle sopravvenienti esigenze di questa era emergenziale, non sia il caso di far luogo ad una ulteriore modifica dell’ordito normativo, sostituendosi il vigente “contestualmente”, di cui alla norma innanzi commentata, con un “preventivamente” ed imponendo tale obbligo (di previa informazione) in presenza di esercizio di potestà regionali sia ampliative che restrittive. Modifica da accompagnarsi con una previsione che subordini l’efficacia dei provvedimenti regionali al previo assenso dello Stato, nel caso per silentium da formarsi entro un termine ristrettissimo. In alternativa, sempre e solo in materie già oggetto di misure antiepidemia emanate in sede nazionale, le competenze delle regioni, dei sindaci, delle aa.ss.ll., e ancora scendendo per li rami, potrebbero essere ricondotte in un alveo di discrezionalità solo tecnica, esclusa quella amministrativa, declinando in tali modi i principi di sussidiarietà in era Covid.
Non mi sfugge che le proposte cui ho fatto fin qui cenno potrebbero offrire il fianco a qualche obiezione/perplessità. Non mi sfugge, ma io ritengo possan superare il vaglio critico e, soprattutto, non mi sfugge che se non si pone termine alla babele delle lingue, degli interventi normativi, alla loro sovrapposizioni, se ciascuno non si assumerà le proprie responsabilità, non scaricandole sui livelli, superiori o inferiori che siano (son di stamattina le contestazioni dei sindaci all’ultimo d.PCM nella parte in cui affida loro la potestà di imporre “coprifuochi parziali” di vie e piazze dalle 21) dal precipizio in cui siamo affondati non ci rialzeremo.
Prima di chiudere, mi vien fatto di allargare un po’ il discorso, pur sempre restando in tema.
In questi giorni tormentati, mi sto interrogando sempre più di frequente, in concomitanza con le evenienze che mi inducono a ripensarvi, se sia percorribile -sempre per i provvedimenti aventi ad oggetto misure di contrasto dell’epidemia e finchè perdurerà lo stato di emergenza- la via di una sospensione della tutela cautelare monocratica, affidata, ex art. 56 c.p.a., ai Presidenti dei TT.AA.RR., per far luogo direttamente, da remoto, a quella collegiale ex art. 55.
La tutela cautelare monocratica già oggi si dispiega per gran parte da remoto, nel senso che redazione, emanazione e pubblicazione dei decreti presidenziali non impongono la presenza in sede, che certo può esservi, ma -in diritto- può mancare ed -in fatto- non di rado manca.
Ma se così è, e se è vero come è vero che la giustizia amministrativa ha mostrato in questi mesi di poter funzionare efficacemente da remoto, assicurando anche il corretto svolgimento delle udienze pubbliche in tale modalità, non si rinvengono ragioni che si frappongano al percorso qui delineato.
E’ ben noto che i provvedimenti in era coronavirus hanno efficacia del tutto limitata nel tempo, di tal che quasi sempre la stessa (efficacia) viene a cessare in tempi antecedenti alle udienze camerali, fissate a cadenza quindicinale. Corollario a questo dato di fatto è che “ … il controllo giurisdizionale appare destinato ad esaurirsi con la tutela cautelare provvisoria assicurata da decreti presidenziali monocratici dei Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, nel mentre la fase del merito, se non anche quella della tutela cautelare collegiale, sarà –naturaliter, stante lo spirare degli effetti delle misure- destinata ad esser definita con pronunce in rito di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fatti salvi, ex art. 34, comma 3, c.p.a., improbabili casi in cui avesse a potersi ravvisare il perdurare dell’interesse ai fini risarcitori” (così già nel sopra cit. “lo ius (mal) positum non ricompone le fratture fra Stato e Regioni”).
Ed allora, perché non porre rimedio? Una volta che oggi lo strumentario tecnico è stato rodato ed ha funzionato perché non utilizzarlo? Questo mio contributo non sottende assolutamente una sorta di mancanza di fiducia per il monocratico (ben lungi il pensiero da me), ma di certo coglie i lati positivi del potersi far luogo ad un vaglio collegiale con possibilità di emanazione di una “sentenza breve”: a vista. Il che non è cosa da poco conto. Va da sé che la temporanea sospensione della tutela monocratica richiesta in relazione ai provvedimenti di cui qui stiam trattando avrebbe ad esser prevista, ed a maggior ragione, ove l’acuirsi dell’epidemia imponesse il ritorno generale alle udienze da remoto.
Certo, non ignoro i profili procedurali e pratici da superare, pur in presenza della tecnologia.
Ma son certo, senza qui appesantire oltre il discorso, che possono essere superati e consentire al giudice amministrativo di dare ancora una volta prova della sua efficienza e della sua capacità di rendere giustizia piena in tempi reali.