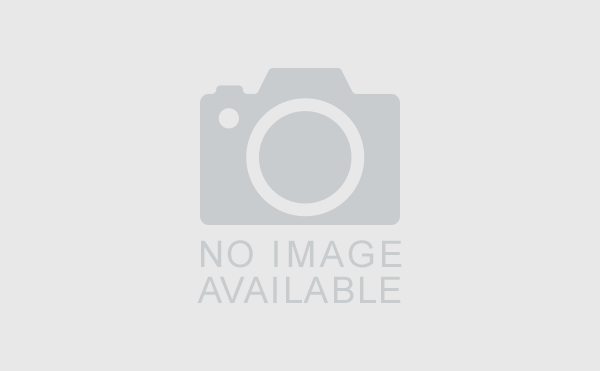𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟓.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐: Il perimetro applicativo della nullità virtuale all’attività ai cd. confidi minori
Il perimetro applicativo della nullità virtuale all’attività ai cd. confidi minori
a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#nullità #virtuale #confidi #minore #art.1418comma1c.c. #art.155T.U.B. #nullità #virtuale
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 8472 del 15/03/2022
La pronuncia in oggetto offre degli ottimi spunti di riflessione sul perimetro applicativo della nullità virtuale, di cui all’articolo 1418, comma 1, c.c.
La questione rimessa alle Sezioni Unite concerne la validità o meno della fideiussione rilasciata da un “confidi minore” a un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario.
Il dubbio sorge dalla circostanza che i confidi minori possono esercitare “esclusivamente” l’attività di garanzia collettiva dei fidi in favore delle imprese consorziate, al fine di favorire il finanziamento da parte delle banche.
In altri termini, i confidi minori possono prestare ai proprio associati delle garanzie per facilitare il finanziamento da parte delle banche. Nel caso di specie, invece, la garanzia fideiussoria, prestata dal confidi minore, era volta a garantire un contratto di tipo non bancario di un proprio associato.
Pertanto, ci si chiede se, atteso che nel caso di specie trovava applicazione l’articolo 155, comma 4, T.U.B. – attualmente abrogato dall’articolo 8, comma 2, d.lg. n.141/2010- che stabiliva che “I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco[…]”, sia possibile sostenere che la fideiussione prestata per un contratto non bancario debba considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, c.c.
Dunque, al fine di risolvere il caso sottoposto alla sua attenzione, il collegio deve verificare se la norma, di cui all’articolo 155, comma 4, T.U.B. sia di tipo imperativo, rilevante, quindi, ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, c.c.
A parere di chi scrive occorre principiare dalla corretta definizione dei confidi.
Il termine confidi rappresenta l’acronimo di “consorzio di garanzia collettiva dei fidi” e si tratta di un consorzio che aiuta le piccole e medie imprese a ottenere mutui e presti dalle banche e dagli istituti di credito.
Essi possono essere di due tipi: maggiori o minori.
Rispettivamente, la prima tipologia di confidi è la più importante e, pertanto, è strettamente vigilata dalla Banca d’Italia. Essi devono avere un capitale che permetta di dare garanzie. Maggiore è il patrimonio di vigilanza e maggiori sono le garanzie di un Confidi e, di conseguenza, l’importo che è possibile ottenere.“I confidi “maggiori”, invece, sono: tenuti a iscriversi nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 (previgente art. 107) T.u.b.; strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali più elevate; assoggettati ad un più penetrante regime di vigilanza (informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d’Italia); “esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi” e “in via residuale… le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco” (art. 13, comma 32, cit.); possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria in via non prevalente rispetto all’attività di garanzia collettiva dei fidi”.
I confidi minori sono i soggetti chesvolgono esclusivamente l’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, in favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Essi si caratterizzano per un patrimonio inferiore- rispetto ai confidi maggiori- e per una minore vigilanza.
Ciò premesso, il collegio passa ad analizzare il concetto della nullità virtuale.
In via generale, è possibile evidenziare che per norma imperativa debba intendersi una norma inderogabilee a presidio di un interesse generale e/o (dipende dalla ricostruzione che si intende avvallare) indisponibile.
La giurisprudenza ha individuato le norme imperative, la cui violazione determina la nullità del contratto, in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale previsto dalle parti. Al riguardo, è opportuno specificare che in tanto è possibile discorrere di nullità virtuale in quanto la norma imperativa stigmatizzi il contratto, inteso come atto. Ciò conduce a sostenere che se la norma sottende un obbligo comportamentale, la sua violazione conduce ad una responsabilità dell’agente e non all’invalidità del contratto, salvo che il legislatore non abbia, preventivamente, elevato la regola di comportamento a regola di validità.
Successivamente la giurisprudenza ha esteso la nullità anche alleviolazioni che riguardano elementi estranei al contenuto del contratto, ricomprendendo nell’area dell’articolo 1418, comma 1. c.c. , quelle che vietano la stipula del contratto da parte di soggetti non autorizzati (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007).
Pertanto, da questa breve ricostruzione è possibile sostenere che la giurisprudenza ha utilizzato la nozione di “norma imperativa” come strumento “[…]di reazione dell’ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali”.
Da ciò consegue, l’eccessiva genericità della nozione e della discrezionalità rimessa al giudice nell’individuazione di nuove ipotesi di nullità “[…]in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali”.
Al riguardo il collegio chiarisce che “In realtà, il rischio paventato può essere evitato se si considera che la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale”.
Conseguentemente, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che in mancanza di specifiche disposizioni proibitive non è possibile ricavare la nullità indirettamente o implicitamente dalle norme che dispongono che i confidi minori esercitano “in via esclusiva” o “esclusivamente” l’attività di garanzia per favorire il finanziamento delle banche in favore delle imprese consorziate.
Invero, “La nullità negoziale, ex art. 1418 c.c., comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art. 41, commi 1 e 2).
In conclusione, la fideiussione prestata da un cd. “confidi minore, come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4 T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali” per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.